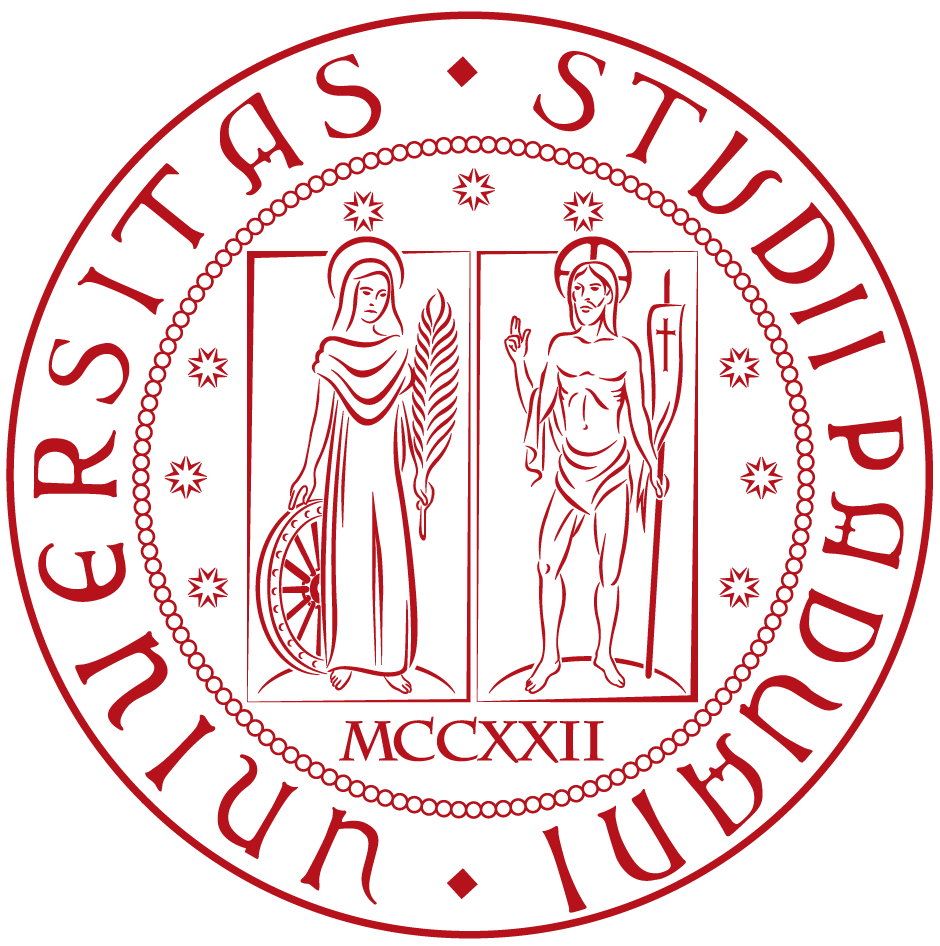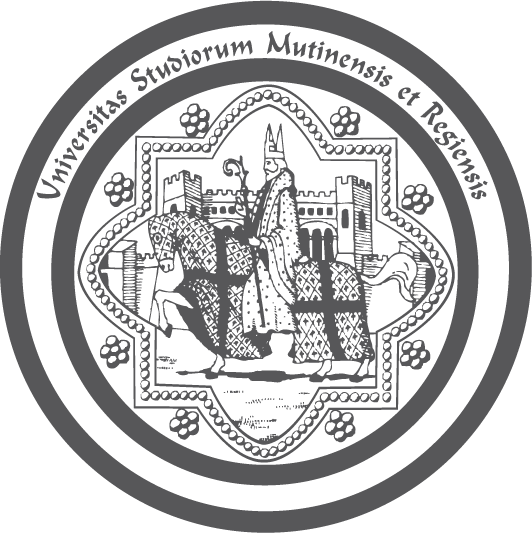Opera lirica
Il melodramma nasce a Firenze verso il 1600. Ma dalla corte medicea il nuovo genere teatrale subito si allontana per trovare casa presso i Gonzaga di Mantova e a Roma, dove dal 1632 la famiglia Barberini patrocina nel proprio palazzo una stagione di opere spesso su testi confezionati dal letterato pistoiese Giulio Rospigliosi, futuro papa Clemente IX.
Pensato inizialmente come intrattenimento cortigiano e d’élite, nella Venezia del 1637 il melodramma approda nei teatri pubblici a pagamento, trasformandosi così in teatro popolare e impresa commerciale. È sui palcoscenici veneziani che accanto a intrecci mitologici e pastorali fanno la prima comparsa anche temi storici (capostipite, nel 1643, L’incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi).
Il modello veneziano d’opera si diffonde a macchia d’olio nel resto della penisola. A metà Seicento fiorisce a Napoli quella che sarà, per due secoli, una grande tradizione di respiro sovranazionale. Per tutto il Settecento Napoli è baricentro produttivo del melodramma e dai suoi Conservatori manda musicisti per ogni dove in Europa, tanto che opera napoletana diviene sinonimo di opera italiana.
All'estero, nelle corti e poi nelle sale pubbliche, l’idioma italiano (nel senso di lingua vera e propria, ma pure di codice drammaturgico, di scrittura musicale e di concezione delle vocalità) resta in vigore, sia pur di frequente aggredito, contestato, combattuto, fino al Romanticismo, quando ogni nazione sentirà la necessità di tracciare percorsi melodrammatici autonomi.
Ma essere nato in Italia non è affatto indispensabile per far l'operista italiano. Georg Friedrich Händel (1685-1759), per esempio, compone opere serie in lingua italiana nonostante la nascita tedesca e l’impiego inglese. E non è che un caso fra tanti. Altri, ancor più celebri, sono quelli di Gluck e di Mozart. Né, d'altronde, gli operisti italiani si fossilizzano solo su quel che sanno fare. L'Ottocento registra diversi casi di musicisti emigrati o ospitati a Parigi, allora capitale culturale del mondo, capaci di intonare libretti in francese adottando una scrittura conforme al gusto d'oltralpe, così diverso da quello nostrano: basti pensare a Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi.
La grande stagione del melodramma romantico, quando l'opera italiana comincia a non essere più l'unica colonizzatrice dei palcoscenici internazionali, culmina appunto in Verdi che nel secondo Ottocento domina le scene solitario, inarrivabile. Finché non giunge Giacomo Puccini a portare avanti la tradizione nazionale grazie alla sua sensibilità nello scegliere soggetti emozionanti e nel rivestirli di stoffe timbriche flessuose e avvolgenti, in linea con quanto di più avanzato stava producendo la musica europea.
La morte di Puccini sembra determinare la fine del melodramma. Finisce in effetti l’opera all’italiana, ma non l’opera italiana. Dalle macerie della seconda guerra, ad esempio, spunta fuori un capolavoro come Il prigioniero (1950) che tratta dell'anelito alla libertà e della sua negazione: ne è autore Luigi Dallapiccola (1904-1975), istriano naturalizzato fiorentino, primo in Italia ad avvalersi del metodo dodecafonico teorizzato dal viennese Arnold Schönberg. E oggi, dopo stagioni di sperimentazione ardua e radicale che hanno sconquassato il teatro musicale dalle fondamenta, sono compositori come Salvatore Sciarrino (1947), Fabio Vacchi (1949) e Giorgio Battistelli (1953) a rinnovare l'attenzione di vaste platee internazionali sulla produzione operistica italiana.
(A cura di Gregorio Moppi)