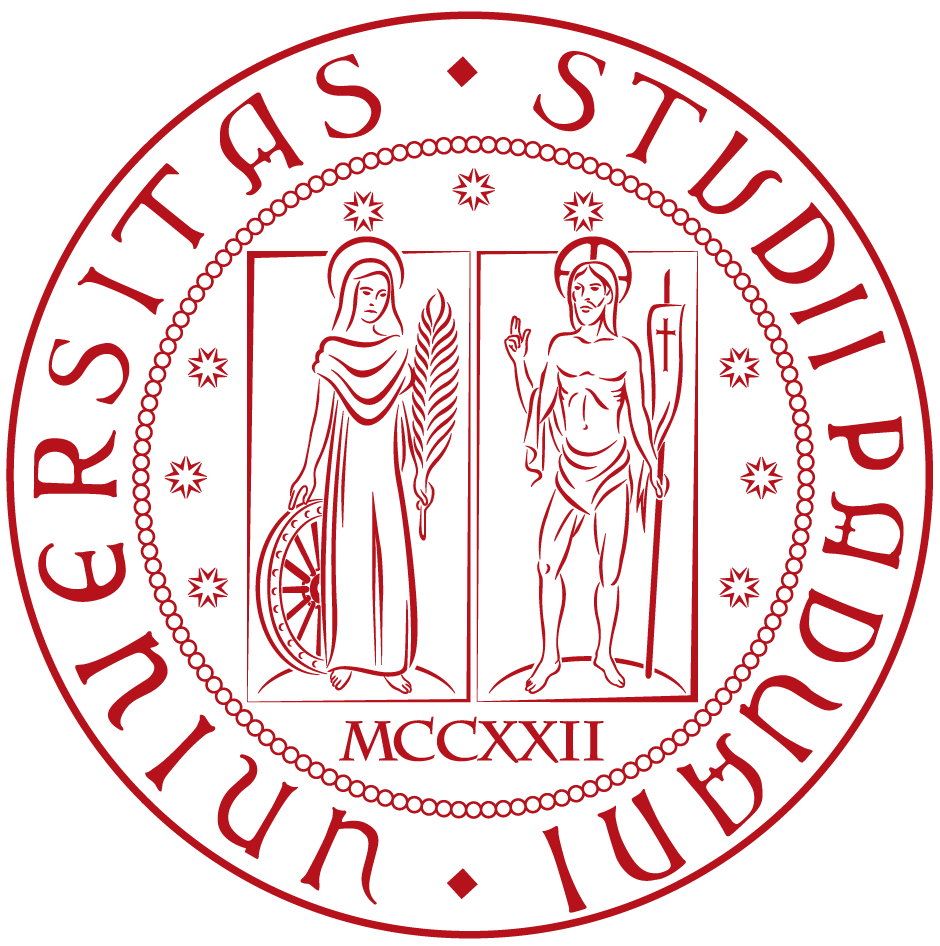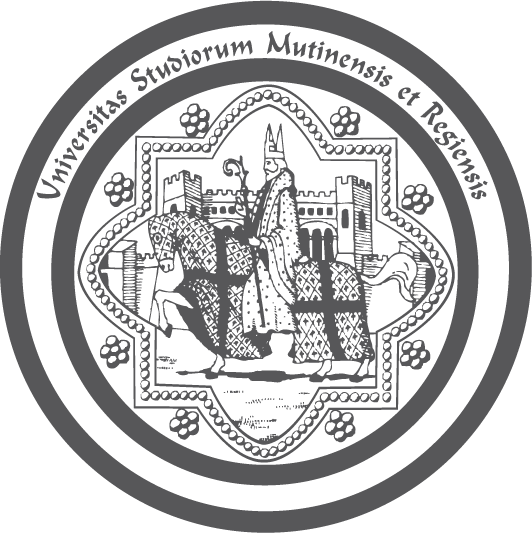5. La “follia organizzata” di Rossini

Isabella, italiana bella e astuta in viaggio per mare alla ricerca dell’innamorato Lindoro, è catturata dai pirati insieme al suo cicisbeo Taddeo. Viene portata ad Algeri, alla corte del bey Mustafà che, stanco della moglie, si invaghisce della prigioniera. La quale finge di cedere alle lusinghe del corteggiatore solo perché lì ha ritrovato, ridotto in schiavitù, il fidanzato Lindoro, e con lui ha intenzione di fuggirsene quanto prima. Ovviamente riesce nell’impresa e Mustafà resta con un palmo di naso. Ecco il soggetto dell'Italiana in Algeri di Gioachino Rossini, opera buffa su libretto di Angelo Anelli data a Venezia nel 1813 quando il compositore non aveva che ventuno anni, e già da tre era in carriera. Un’opera che (con le sorelle che la seguono: Il turco in Italia, Milano 1814; Il barbiere di Siviglia, Roma 1816; La Cenerentola, Roma 1817) si distanzia decisamente dalla tradizione buffa napoletana che impazzava per l’Europa. E non solo perché il pesarese Rossini non era napoletano né aveva studiato a Napoli (anche se vi avrebbe lavorato), ma era stato allievo a Bologna di padre Stanislao Mattei, contrappuntista erudito, e si era fatto le ossa anche studiando i lavori di Haydn e Mozart di cui poco l’Italia d’allora si curava.
La differenza tra l’opera buffa rossiniana e quella napoletana non sta nella struttura architettonica (in entrambe i recitativi si alternano ad arie, duetti, concertati) o nell’assetto della trama (gli innamorati devono superare ostacoli prima di poter mettersi insieme). Innovative sono piuttosto l’ energia ritmica e la carica surreale con cui Rossini infiamma l’opera. Il finale del primo atto dell’Italiana ne è dimostrazione esaltante. Tutti i protagonisti si ritrovano sulla scena. Condizione assai caotica perché ciascuno ha un problema da risolvere e riflette tra sé, ma a voce alta, mentre simultaneamente gli altri fanno lo stesso. Cosicché i pensieri dei singoli formano una costruzione a più voci: impossibile distinguere le parole, si sentono solo fonemi cozzare tra loro. Le idee sono confuse. C’è chi sente in testa un campanello fargli din din, chi un cannone fargli bum bum, chi una cornacchia spennata fargli crà crà, chi un martello fargli tac tà. “Follia organizzata”, secondo la definizione di Stendhal. Il meccanismo musicale congegnato da Rossini, l’urto di sillabe deprivate di senso e accavallate alle note, ha spersonalizzato tutti i caratteri tramutandoli in marionette. Quasi un'anticipazione di esperimenti novecenteschi.
E pensare che Rossini, per indole, era tutt’altro che rivoluzionario. In politica temeva l’instabilità e, come tanti colleghi, sapeva assoggettarsi facilmente al regime di turno. Quando nel Risorgimento ne biasimarono lo scarso coinvolgimento patriottico, lui ribatté additando ai maldicenti proprio una pagina dell’Italiana, quella in cui Isabella canta “Pensa alla patria, e intrepido / il tuo dover adempi”. Anche nel canto Rossini prediligeva una tecnica d’antico regime improntata al bello ideale: pura eleganza priva di forzature, emissione levigata, uguale in tutti i registri perfino nei passaggi più virtuosistici. D'altronde considerava la musica, di per sé, asemantica, capace di acquistare significato soltanto nel suo farsi situazione drammatica. Tant’è che un motivo d’effetto comico nel Barbiere di Siviglia scritto per Roma poteva pure essere impiegato, con risultati del tutto opposti, nel momento più tragico del coevo Otello scritto per Napoli.
Perciò quando il gusto del pubblico virò verso vocalità più robuste e sanguigne che sbaragliavano la concezione del belcanto di matrice settecentesca, il compositore preferì ritirarsi dalle scene inorridito da quelle che a lui parevano urla di capponi sgozzati. Era il 1829. Sarebbe morto quasi quarant’anni dopo, uscendo di rado dal silenzio musicale autoimpostosi.