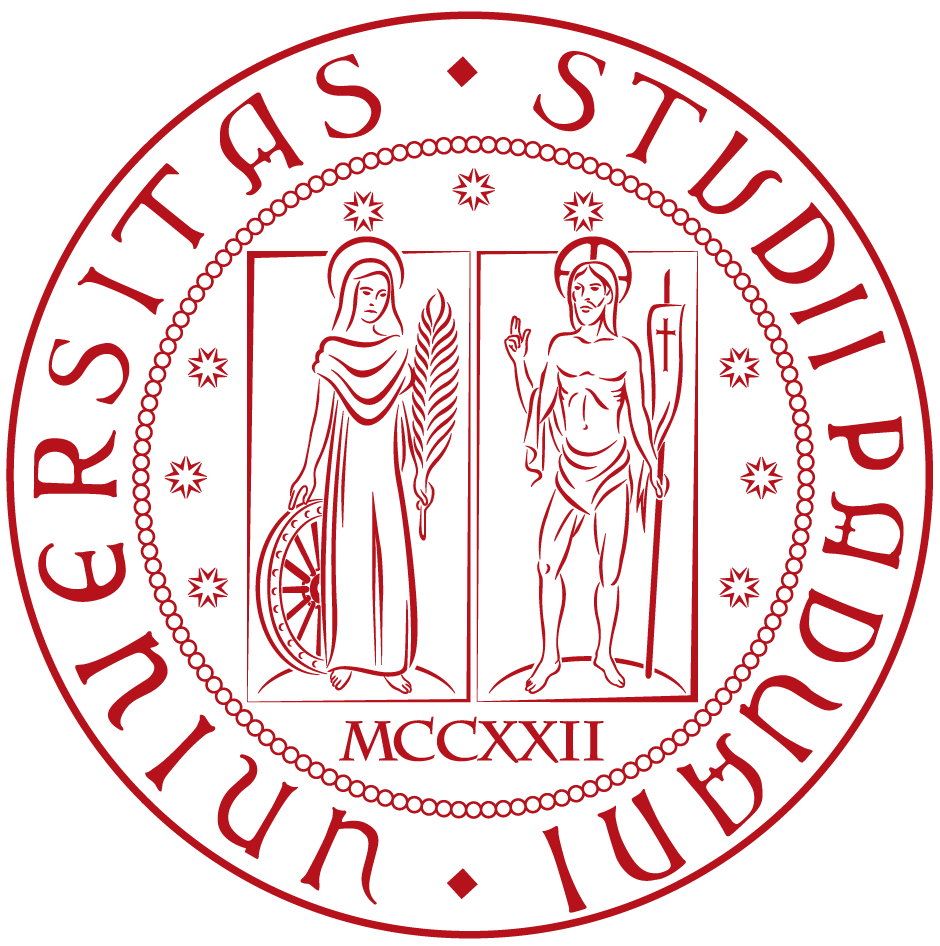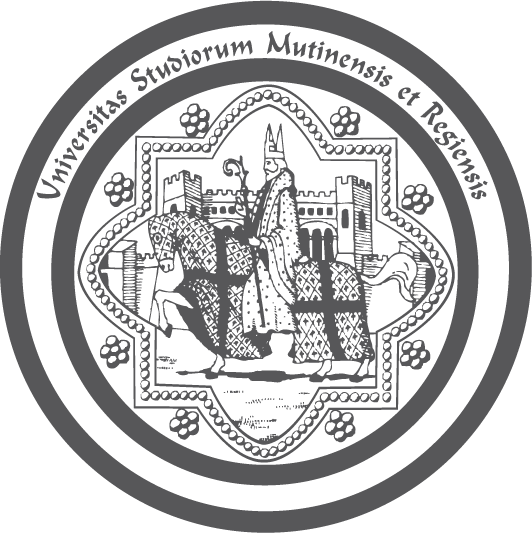8. La preservazione dell'identità nazionale nelle «Altre Italie»

I processi di nazionalizzazione degli italiani all’estero sono stati storicamente soggetti a numerose variabili: contesti di insediamento, epoche storiche, scelte politiche dell’Italia e dei paesi di accoglienza, cambiamenti generazionali hanno profondamente influito sulla formazione dell’italianità. In ogni caso, tutti gli studi concordano nel rilevare che, fino al fascismo, la coscienza nazionale, assente nei migranti all’atto di partire, si sviluppò nei paesi di insediamento attraverso il confronto con l’altro e con le stesse élite italiane delle nuove comunità. In seguito, le politiche del fascismo volte a una propaganda mirata, indirizzata alle collettività italiane all’estero, portarono allo sviluppo di sentimenti di italianità tra immigrati divisi in mille lealtà campanilistiche.
Peraltro l’avvento delle seconde generazioni e le politiche assimilazionistiche di molti paesi di immigrazione fecero sì che l’italianità si sviluppasse parallelamente all’integrazione nelle società ospiti. Nei decenni successivi alla Seconda guerra mondiale, infine, si passò da un sostanziale distacco dalla madrepatria alla «scoperta delle radici», che conciliò il successo dell’inserimento con un rinnovato interesse per l’Italia.
Si tornò in tal modo a guardare ai propri paesi di origine, ma all’interno di una visione del tutto nuova. Ciò dette adito a quello che è stato definito il revival dell’ethnicity, che iniziato negli Stati Uniti, ha influenzato i principali paesi di emigrazione portando, oltre che all’adozione di politiche educative e comunitarie di matrice multiculturale in Canada e in Australia, a uno sviluppo dello studio della lingua italiana da parte dei discendenti, al viaggio in Italia per scoprire le proprie radici, ma anche per visitare le città d’arte. A partire dagli Stati Uniti si cominciarono a studiare nei paesi di grande presenza italiana le storie delle varie emigrazioni e a rivalutarne le culture.
Fu solo alla fine degli anni sessanta, con il revival dell’etnicità negli Stati Uniti che le minoranze etniche bianche di origine europea, molte delle quali oramai giunte alla terza generazione, impararono a sentirsi americane senza dovere rinnegare le proprie origini, anzi, poterono rafforzare il loro essere americane attraverso l’identificazione etnica, rifiutando il melting pot e riscoprendo con orgoglio le proprie radici. La storia, la lingua, l’arte, ma anche la cucina italiana divennero oggetto di rivalutazione.
La lingua degli emigrati
Gli emigrati, svilupparono una lingua franca italiana che permetteva loro di dialogare con i connazionali di diverse regioni: una koinè ben lontana dalla lingua di Dante, intrisa di termini dialettali e di una storpiatura delle lingue autoctone dei paesi di insediamento: koinè che venne chiamata a seconda dei casi «la lingua del iesse» negli Stati Uniti, il «lunfardo» e il «cocoliche» in Argentina, il «talian» in Brasile e così via. Talvolta, il dialetto divenne addirittura la lingua dominante, come accadde nelle comunità più chiuse: è il caso del veneto nel Rio Grande do Sul in Brasile o del piemontese nella Pampa Gringa in Argentina. In entrambi i casi il comportamento linguistico degli emigrati costituiva rispettivamente un sintomo dell’integrazione nel nuovo paese o della persistenza di un legame con la comunità locale originaria, piuttosto che con l’Italia.