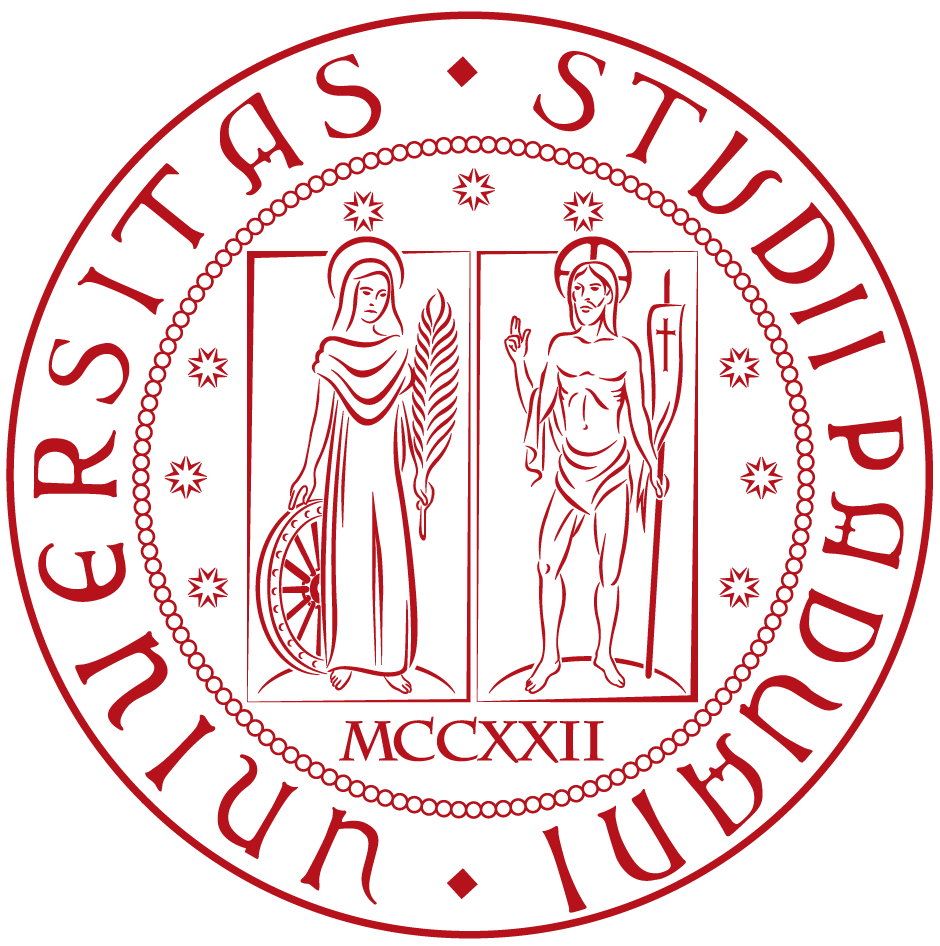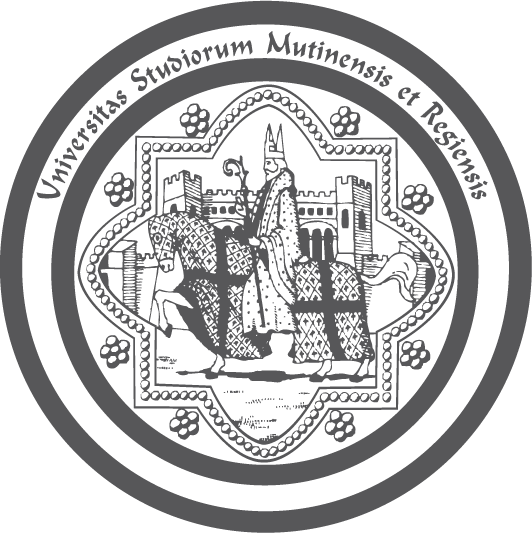10.2. Le mille vie dell’italianità

- La ricerca dell’italianità
Nel 1910 la rivista senese «Vita d’arte» istituì il concorso per un abito femminile da sera per promuovere la creatività italiana: vinse Francesco Nonni che, sulle orme di Rosa Genoni ritenne che uno stile nazionale dovesse ispirarsi alle opere dei principali artisti di Medioevo e Rinascimento. Il dialogo con la tradizione, l’abilità delle maestranze e la capacità ideativa al servizio del lusso si profilavano già allora come i tratti costitutivi della moda italiana che cominciava a delinearsi come ambito specifico all’interno del dibattito sulle arti decorative. A Roma nel 1919, il "Primo Congresso Nazionale dell'Industria del Commercio dell'Abbigliamento" fu abbozzato il disegno teso ad affermare un carattere italiano della moda e a potenziare l’industria locale “affrancandola dalle influenze straniere”. Nel ventennio fascista il progetto acquisì compattezza e sistematicità: nel 1932 fu costituito l’Ente autonomo per la Mostra nazionale permanente della moda, convertito nel 1935 in Ente Nazionale della Moda più efficace nel coordinare l’intero ciclo produttivo «con unità di indirizzo e di azione […] in una sola e organica linea di lavoro il sarto modellista, l’industriale tessile, quegli affini all’abbigliamento, e l’artista creatore». Le circa 300 ditte ammesse dovevano apporre un talloncino a “marca di garanzia” di italianità, previa controllo dell’Ente stesso, modello per modello. Si può immaginare in quali pastoie burocratiche si arenava la produzione “Doc”! Difficile ricavare da pubblicazioni dell’epoca spie su falle del sistema-moda del regime, poiché alla stampa fu imposta una ferrea censura, oltre all’invito (!) di evitare ogni riferimento a creatori e produzioni parigine. Ma si sa, è costitutivo della moda essere controcorrente, così proliferò la lettura clandestina di periodici esteri e le signore, soprattutto del bel mondo, potevano confrontare le modeste fotografie filtrate dall’Ente (Luxardo ne era il fotografo “ufficiale”), con quelle di riviste come Vogue, Harper’s Bazaar, Vanity Fair, scattate da geni dell’obbiettivo come Edward Steichen o Cecil Beaton, che hanno veicolato le immagini delle dive hollywoodiane come Joan Crawford, Norma Shearer, Greta Garbo, Katharine Hepburn, con i total look creati dal “mago” americano Adrian, come i celebri tailleurs di taglio mascolino di Marlene Dietrich, che sono stati longeva fonte di ispirazione, da Yves Saint Laurent a Giorgio Armani. (cfr. Gnoli, 2012, p.71).
Erano quelle le vere icone imposte dal cinema, anche per signore e massaie d’Italia, nonostante lo sforzo dispiegato dalla cinematografia del ventennio, come nella Contessa di Parma (1937) di Alessandro Blasetti, o i Grandi Magazzini (1939, girati alla nuova UPIM) di Mario Camerini, apoteosi della politica espansiva della distribuzione: la Rinascente, la UPIM, la Standard (poi Standa)…, che, “aiutati” dalle leggi razziali, oscurarono la fama dei Magazzini Cohen (dal 1880 in via del Tritone, come segnalato sulle guide turistiche di Roma), all’apice tra gli anni '20 e '30, con i loro vasti assortimenti delle migliori fabbriche nazionali ed estere, la produzione di ricami e di "lavori di stile e precisione", eseguiti nei laboratori ai piani alti del palazzo. I quattro fratelli Coen, con precoce attenzione alla moda maschile, si recavano a Londra e Parigi quattro volte l'anno per la scelta di stoffe per abiti, camicie e cravatte; in Piemonte, a Biella, si rifornivano di telerie italiane. A Roma si tagliava e si confezionava. John Guida si occupava per loro, dal 1914, della donna: eccellente e aggiornatissimo figurinista (a via del Tritone tenne anche un corso di formazione per tale professione emergente): "Per creare una moda nostra, la moda del nostro buon gusto veramente italiano, ad ogni mutare di stagione io prendo il treno e vengo a fare una passeggiata a Parigi.......Perché non si può negare ai nostri amici d'oltre Alpi di essere i despota in fatto di mode femminili. Io guardo, ammiro, studio e targo le mie deduzioni, sulle quali poi lavoro”. I modelli che la ditta Coen ne ricavava furono messi in vendita dal 1936 anche in carta. Guida, due volte la settimana, allestiva le undici vetrine dei Magazzini: i figurini su cartoncino colorato, solitamente cm. 50x70, marchiato "S. di P. Coen", vi erano sistemati con attorno i tessuti “giusti” per la realizzazione dell'abito, drappeggiati con sicuro effetto da John, che nobilitò anche un’altra professione della moda: l’arte del vetrinista.
- La ricerca dei materiali e sui tessuti
L’opera patriottica sulla moda proseguiva, grazie anche alla regina Margherita e Edda Mussolini, e all’attivissima Lydia De Liguoro, fondatrice di «Lidel» (il ruolo delle riviste di moda fu fondamentale e tante ne nacquero); furono banditi concorsi con il contributo di artisti futuristi come Marinetti, Balla e Depero e nel 1928 si aprì, proprio a Parigi, la Boutique italienne, una vetrina permanente della migliore produzione italiana d’arte e artigianato (attiva fino al ’34), col contributo determinante di Maria Monaci Gallenga, dopo il grande successo dei suoi tessuti all’Expo parigina del ’25. Vicina agli artisti della “Secessione Romana” come Gino Sensani, Galileo Chini, Romano Romanelli e Marcello Piacentini, Maria amava organizzare mostre e promuovere giovani artisti, confermando la consanguineità fra arte e moda. Sperimentatrice, per le proprie creazioni di moda e arredo brevettò un’esclusiva tecnica di stampa su tessuto portando avanti la ricerca di Mariano Fortuny.
Il nazionalismo fascista sostenne la ricerca di tessuti nazionali, non solo con la valorizzazione di fibre rustiche, dalla lana “casentino”, all’orbace, fino alla ginestra (oltre al velluto, tessuto autarchico per eccellenza), ma “tutte le più impensate combinazioni di fibre tessili sono state escogitate per creare la più ricca qualità di tessuti” (“Dea”, Le fibre tessili, 1937). E Roberto Papini seppe dare un tocco letterario a questo sforzo: “Chimica e fisica danno ai tessuti ricchezze nuove che la storia non ha mai conosciuto. Velluti leggeri come crespi, damaschi morbidi quanto veli, […] gli ibridi più bizzarri, crespi damascati e tulli vellutati e garze broccate e maglie rasate, in milioni di sfumature e di toni che anche Iride se tornasse resterebbe a bocca aperta” (cit. in Gnoli, 2012, p.95). Anche Marinetti nobilitò con Il poema del vestito di latte, la campagna pubblicitaria disegnata da Bruno Munari per il lancio pubblicitario del “Lanital” nel 1937. Divagazioni poetiche a parte, si aprì l’era della “SNIA viscosa” e delle altre ditte produttrici di rayon, che fu usato in questi anni sempre maggiormente, non solo nei calzifici, ma anche nell’abbigliamento, declinato in molte varietà: viscosa, acetato, fiocco... misto a lana, cotone oppure seta, oppure da solo, uso che fu facilitato dall’invenzione più “naturale” filo opaco. Anche Elsa Schiapparelli fu una grande sperimentatrice di fibre nuove, mai allora pensate per gli abiti, compresa la plastica trasparente, aprendo la strada ai vari Courreges e Rabanne, per non parlare di Salvatore Ferragamo, che nobilitò il settore della calzatura finora considerato accessorio anche grazie all’uso di materiali alternativi, come la famosa scarpa ortopedica con la zeppa di sughero che negli anni ’40 riuscì a conquistare la duchessa Visconti di Modrone.
Anche il recupero avviato dalla fine Ottocento sull’artigianato locale e sulla manifattura italiana si intensifica nel ventennio, proseguendo l’istituzione di scuole e laboratori per il ricamo e il merletto (favorite dallo stato di arretratezza industriale) e la modisteria (di gran moda i fantasiosi cappellini!). In linea con la riscoperta dell’accessorio anche la pelletteria e calzoleria e al genio Ferragamo si aggiunsero anche Gucci, Gherardini e Roberta di Camerino.
Nonostante la politica di semplificazione e riduzione dei pezzi del guardaroba femminile (mise-base: gonna godet al ginocchio e camicette infilate nella gonna), si concedeva un certo lusso negli abiti da sera e nell’abito da sposa, tanto più in matrimoni “titolati” come quelli delle due “famiglie regnanti” italiane: nel 1930 si celebrarono i matrimoni del principe Umberto di Savoia e Maria José del Belgio, poi del conte Galeazzo Ciano con Edda Mussolini ed entrambe le spose omaggiarono, ovviamente, la sartoria italiana.
- La tradizione sartoriale:
Per identificare un creatore italiano dobbiamo arrivare alla metà dell’Ottocento e al sarto milanese Pietro Prandoni, fornitore della Real Casa, che dal 1862 vestì gli uomini più importanti dell’epoca, da industriali a finanzieri, da Verdi a Puccini. Il valore “aggiunto” dato agli abiti «di sartoria» dai clienti eccellenti, suggerì a Giovanni Battista Rosti, che ne rilevò l’atelier alla morte di Prandoni di mantenerne la «firma», aggiungendo al carnet anche il nome di Gabriele D’Annunzio, vero cultore in materia che seppe dire la sua fino alla morte, nel 1938, alla vigilia del precipizio della seconda guerra mondiale.
Anche se i più geniali stilisti erano, o operavano, soprattutto all’estero, tra Otto e Novecento le principali città d’Italia pullulavano di laboratori sartoriali dove sotto la direzione della caposarta o première, centinaia di «caterinette» (dalla protettrice Santa Caterina, che le sartine ogni 25 novembre celebravano festosamente) lavoravano alacremente. Torino, all’inizio del Novecento era considerata la capitale italiana della moda, con circa 30.000 «caterinette», pari a un quinto della forza lavoro femminile. Occupate in un migliaio fra atelier, laboratori e botteghe di vario rango (molte anche a domicilio, situazione che si rivelerà strategica), le donne monopolizzarono il settore della sartoria, fatta eccezione per la figura del couper, il tagliatore, tradizionalmente maschile.
Napoli, tra gli anni ‘20 e ‘30 del Novecento era una delle città più eleganti d’Italia grazie ai suoi sarti (di cui il più celebre era Vincenzo Attolini), che operavano in botteghe strutturate su quelle del Rinascimento ed erano da allora considerati i più abili: i più famosi tessutai britannici concedevano solo ai sarti partenopei l’uso dei loro tessuti. Anche in molte altre parti d’Italia si andava comunque affermando l’arte della sartoria: così in Emilia-Romagna come in Lombardia o in Abruzzo dove “i sarti sapevano trasformare la materia in capolavori” parola di Gabriele D’Annunzio!
Comunque, anche negli anni ’40, nonostante la “marca oro” istituita dall’Ente Nazionale della Moda, le più stimate case di moda (Zecca, Montorsi, Ferrario, Biki, fino a Calabri, per citarne solo alcune, oltre alla rinomata Ventura, a cui è legato il nome di Fernanda Gattinoni, un ponte al futuro della moda italiana) continuarono le loro “ispirazioni sul tema” dalle passerelle parigine.