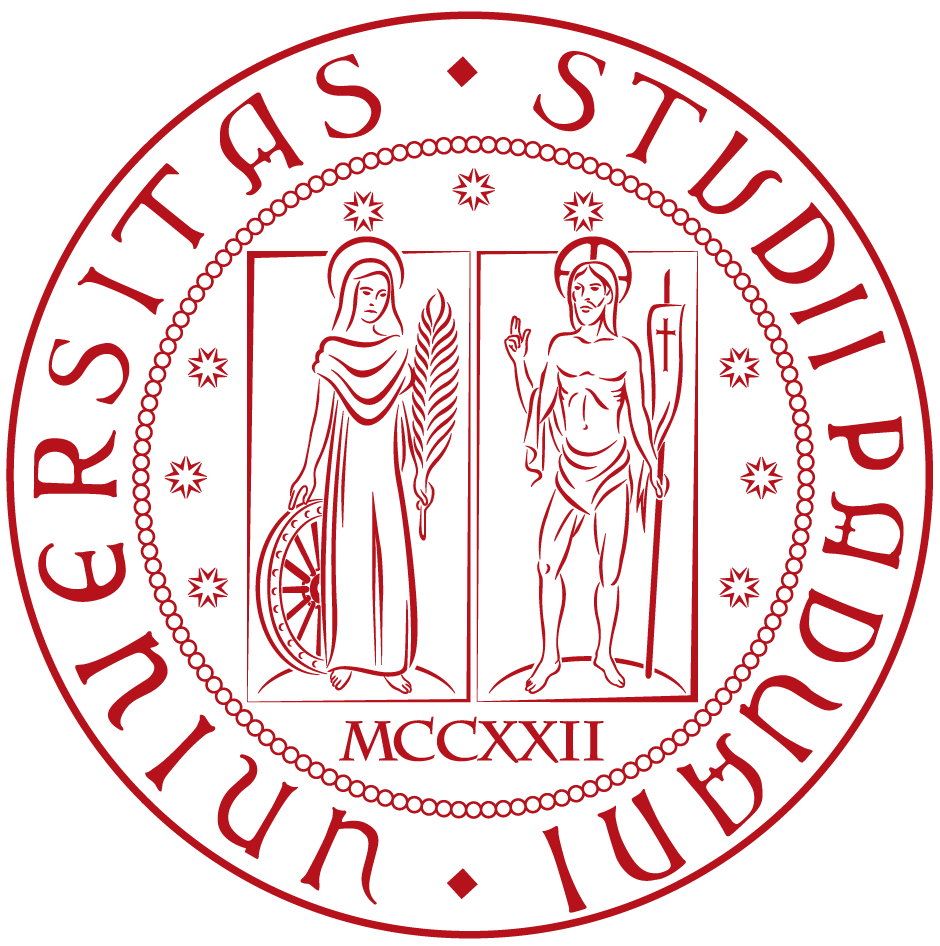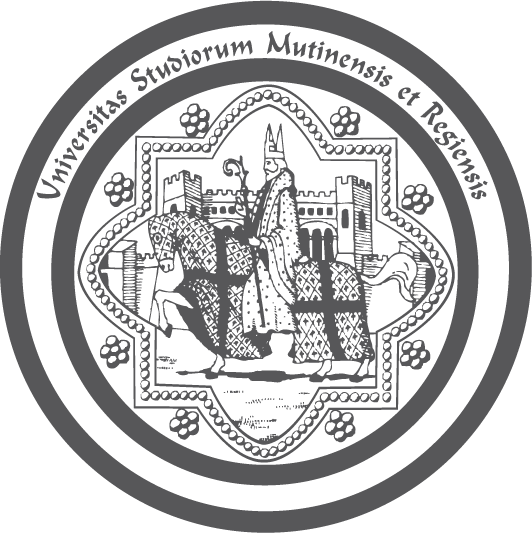La morte di Ermengarda - Coro dell'atto IV

Nel monastero di San Salvatore a Brescia dove si era rifugiata dopo l'abbandono da parte del marito, Ermengarda apprende che Carlo si è sposato nuovamente, e non regge al dolore.
Il coro descrive l'infelice sorella di Adelchi nei momenti che precedono la sua fine Рle morbide trecce sparse sul petto affannoso, le mani abbandonate, il volto pallido imperlato dal sudore per la morte ormai vicina Рutilizzando una costruzione sintattica chiamata accusativo alla greca[1]. Nei versi Sparsa le trecce morbide/ sull'affannoso petto, l'aggettivo sparsa è concordato al femminile singolare della persona che viene descritta (la pia, riferito a Ermengarda), mentre le trecce morbide in funzione di accusativo esprimono il complemento di limitazione. Troviamo la stessa costruzione anche nei versi lenta le palme, e rorida/ di morte il bianco aspetto.
Sparsa le trecce morbide
Sull'affannoso petto,
Lenta le palme, e rorida
Di morte il bianco aspetto,
Giace la pia, col tremolo
Sguardo cercando il ciel.
Cessa il compianto: unanime
S'innalza una preghiera:
Calata in su la gelida
Fronte, una man leggiera
Sulla pupilla cerula
Stende l'estremo vel.
Il coro rievoca il tempo passato, le immagini dei giorni felici che di notte tornano alla mente di Ermengarda anche senza che lei lo voglia (irrevocati dì), impedendole di dormire e di trovare pace: il suo arrivo in Francia (Franco lido) piena di gioia (ebra) per le future nozze e inconsapevole del destino che l'attende; la vita felice di sposa amata e innamorata che segue con trepidazione (pallida/d'amabile terror) il marito intento alla caccia o lo osserva rapita mentre si bagna nelle acque termali (tepidi/lavacri) di Aquisgrana:
Ahi! nelle insonni tenebre,
Pei claustri solitari,
Tra il canto delle vergini,
Ai supplicati altari,
Sempre al pensier tornavano
Gl'irrevocati dì;
Quando ancor cara, improvida
D'un avvenir mal fido,
Ebbra spirò le vivide
Aure del Franco lido,
E tra le nuore Saliche
Invidiata uscì:
Quando da un poggio aereo,
Il biondo crin gemmata,
Vedea nel pian discorrere
La caccia affaccendata,
E sulle sciolte redini
Chino il chiomato sir;
E dietro a lui la furia
De' corridor fumanti;
E lo sbandarsi, e il rapido
Redir dei veltri ansanti;
E dai tentati triboli
L'irto cinghiale uscir;
E la battuta polvere
Rigar di sangue, colto
Dal regio stral: la tenera
Alle donzelle il volto
Volgea repente, pallida
D'amabile terror.
Oh Mosa errante! oh tepidi
Lavacri d'Aquisgrano!
Ove, deposta l'orrida
Maglia, il guerrier sovrano
Scendea del campo a tergere
Il nobile sudor!
Ermengarda è combattuta fra il desiderio di dimenticare il passato e l'amore che la spinge a ricordare i momenti di felicità ormai perduti (sempre un obblio di chiedere/ che le saria negato vv. 20-21). Per descrivere questo dramma interiore il coro utilizza immagini mutuate dalla natura, concrete, accessibili ed efficaci. Le parole caritatevoli delle suore, simili alla rugiada che ridà vita a un ciuffo d'erba (cespite) inaridito dal sole, scendono benefiche su Ermengarda, indirizzando il suo cuore (il cor diverte) verso l'amore per Dio (un altro amore). Ma, come il sole torna a infiammare il cielo (l'erta infocata ascende), così, dopo un attimo di dimenticanza (tenue/obblio), l'amore per Carlo torna ad assalire Ermengarda e riporta nel suo animo il dolore di sempre (noto duol):
Come rugiada al cespite
Dell'erba inaridita,
Fresca negli arsi calami
Fa rifluir la vita,
Che verdi ancor risorgono
Nel temperato albor;
Tale al pensier, cui l'empia
Virt√Ļ d'amor fatica,
Discende il refrigerio
D'una parola amica,
E il cor diverte ai placidi
Gaudii d'un altro amor.
Ma come il sol che reduce
L'erta infocata ascende,
E con la vampa assidua
L'immobil aura incende,
Risorti appena i gracili
Steli riarde al suol;
Ratto così dal tenue
Obblio torna immortale
L'amor sopito, e l'anima
Impaurita assale,
E le sviate immagini
Richiama al noto duol (vv. 61-84)
Il coro invita Ermengarda a staccarsi delle passioni terrene (terrestri ardori) e ad accettare serenamente il suo destino di vittima innocente, inviata dalla provvidenza a riscattare il dolore che la malvagia stirpe (rea progenie) dei Longobardi ha causato ad altre donne innocenti come lei (altre infelici). La sventura di Ermengarda, quindi, non √® priva di senso e di significato, ma √® frutto di un disegno divino, provvidenziale, espresso nell'ossimoro provvida/sventura. In questa accettazione sostenuta dalla fede, Ermengarda trova finalmente pace e la serenit√† compare di nuovo sul suo viso, simile al sole che, dopo un giorno di tempesta, si affaccia fra le nuvole (dalle squarciate nuvole/si volge) e porta la speranza di un giorno pi√Ļ sereno al contadino fiducioso nella misericordia divina (pio):
Sgombra, o gentil, dall'ansia
Mente i terrestri ardori;
Leva all'Eterno un candido
Pensier d'offerta, e muori:
Nel suol che dee la tenera
Tua spoglia ricoprir,
Altre infelici dormono,
Che il duol consunse; orbate
Spose dal brando, e vergini
Indarno fidanzate;
Madri che i nati videro
Trafitti impallidir.
Te dalla rea progenie
Degli oppressor discesa,
Cui fu prodezza il numero,
Cui fu ragion l'offesa,
E dritto il sangue, e gloria
Il non aver pietà,
Te collocò la provida
Sventura in fra gli oppressi:
Muori compianta e placida;
Scendi a dormir con essi:
Alle incolpate ceneri
Nessuno insulterà.
Muori; e la faccia esanime
Si ricomponga in pace;
Com'era allor che improvida
D'un avvenir fallace,
Lievi pensier virginei
Solo pingea. Così
Dalle squarciate nuvole
Si svolge il sol cadente,
E, dietro il monte, imporpora
Il trepido occidente:
Al pio colono augurio
Di pi√Ļ sereno d√¨. Vv 85 -120)
[1] √ą una costruzione propria della lingua greca antica (da cui il suo nome) ma presente anche in altre lingue. Consiste in accusativo retto da un participio passato o da un semplice aggettivo con valore di complemento di limitazione.