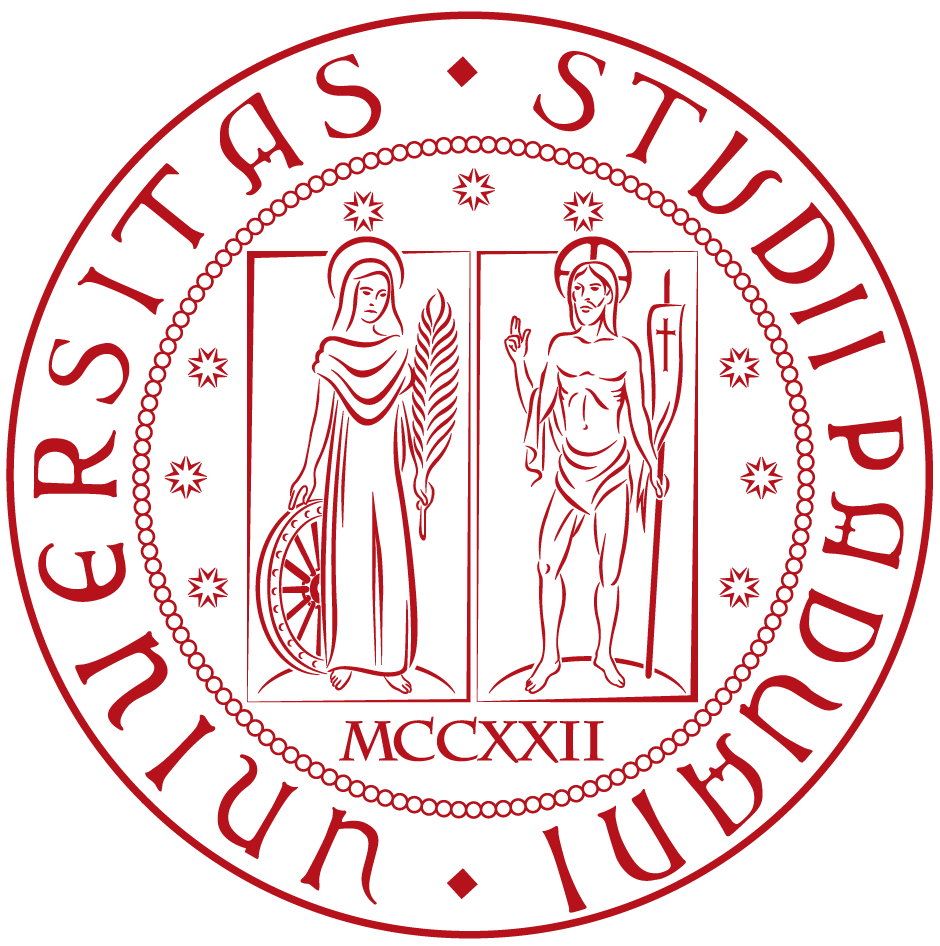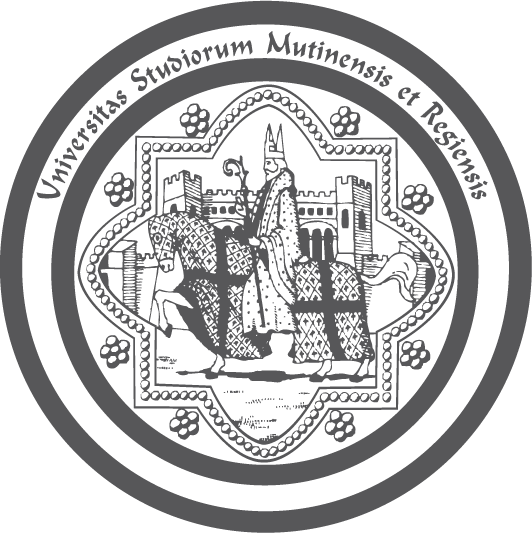Il linguaggio colloquiale nel teatro di Goldoni

Assumendo il saggio di Folena come punto di partenza per il proprio discorso, il linguista Pietro Trifone[1] fa notare come nella lingua delle commedie di Goldoni, italiano e dialetto non contraggano un rapporto di opposizione, ma tendano piuttosto all’incontro e all’integrazione reciproca partendo dalla scelta di un registro del dialetto veneziano che un altro linguista, Alfredo Stussi, definisce «medio e dell’uso civile, proprio di quegli ambienti borghesi che sono tipici di numerosissime commedie dialettali»[2]. Goldoni insomma si rifà al Libro del “suo” Mondo, dunque alla sua lingua materna, perché di questa domina i registri e gli usi colloquiali tipici del parlato dell’area cittadina: «[…] essendo la commedia una imitazione delle persone che parlano più di quelle che scrivono, mi sono servito del linguaggio più comune, rispetto all’universale italiano. Circa al nostro vernacolo veneziano, so che me n’intendo bastantemente per credere che sia scritto come si parla»[3].
Il dialetto veneziano tipico soprattutto delle prime commedie non va inteso come assunzione di una lingua “locale” destinata alla comunicazione con il pubblico di un’area ristretta, come di solito avviene nel teatro dialettale, ma come momento di avvio per la sperimentazione di un nuovo parlato teatrale (il «parlato-recitato» di cui ha scritto Giovanni Nencioni[4]) che porti in scena, con adeguati accorgimenti linguistici, la realtà della conversazione quotidiana. Scrive Trifone:
Il sincretismo della lingua goldoniana, nella quale coesistono calchi di veneziano, forme letterarie, screziature auliche, modi toscani, fraseggi colloquiali e frequenti francesismi, riflette la natura sperimentale di uno strumento che vorrebbe soddisfare esigenze di ancoramento realistico e di generalizzazione comunicativa.[5]
Come si comprende dalla lettura della Locandiera, oramai scritta prevalentemente in italiano, più che sul piano lessicale, Goldoni lavora sul piano della sintassi perché intuisce che questo livello del linguaggio è il cardine per lo scrittore di teatro, quello che gli consente di introdurre sulla scena le movenze del parlato senza rimanere vincolato al dialetto e senza scadere nel popolare. Introduce così tratti assai comuni nella lingua parlata, anche se allora censurati dalla grammatica normativa destinata alla lingua scritta: la dislocazione a sinistra con ripresa pronominale («Ed io quel che fo non lo dico»), il ci attualizzante («ci ho gusto»), il che polivalente, le riprese lessicali tra le battute dei personaggi, che contribuiscono fortemente a rendere coeso il dialogo («Pensano che le donne della vostra sorte si vincano con i regali» «I regali non fanno male allo stomaco»)[6].
Pur rimanendo sempre attento a non deludere i gusti del suo pubblico o, tantomeno, a proporgli scelte spiazzanti, Goldoni pose mano a una riforma del linguaggio teatrale, e della stessa commedia, che trovò séguito in drammaturghi sette-ottocenteschi come Giovanni Giraud, Alberto Nota, Paolo Ferrari i quali, tuttavia, non raggiunsero il livello artistico del commediografo veneziano. Bisognerà attendere la fine dell’Ottocento e il Novecento perché la sua lezione linguistica e teatrale sia recepita da grandi autori come Pirandello e Eduardo De Filippo.
[1] Pietro Trifone, Goldoni: scoperta e invenzione dell’italiano colloquiale, in Id., L’italiano a teatro. Dalla commedia rinascimentale a Dario Fo, Pisa-Roma, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, 2000, pp. 72-80.
[2] Alfredo Stussi, Carlo Goldoni e l’ambiente veneziano, in E. Malato (a cura di), Storia della letteratura italiana, VI. Il Settecento, Roma, Salerno ed., 1998, pp. 877-933.
[3] In Marzia Pieri (a cura di), Il teatro italiano, IV. Carlo Goldoni, Torino Einaudi, 1991, t. III, p. 1285.
[4] Giovanni Nencioni, Parlato-parlato, parlato-scritto, parlato-recitato, in Id., Di scritto e di parlato. Discorsi linguistici, Bologna, Zanichelli, 1983, pp. 126-79.
[5] Pietro Trifone, Op. cit., p.73.
[6] Gli esempi sono tratti da Pietro Trifone, Ivi, p.77.