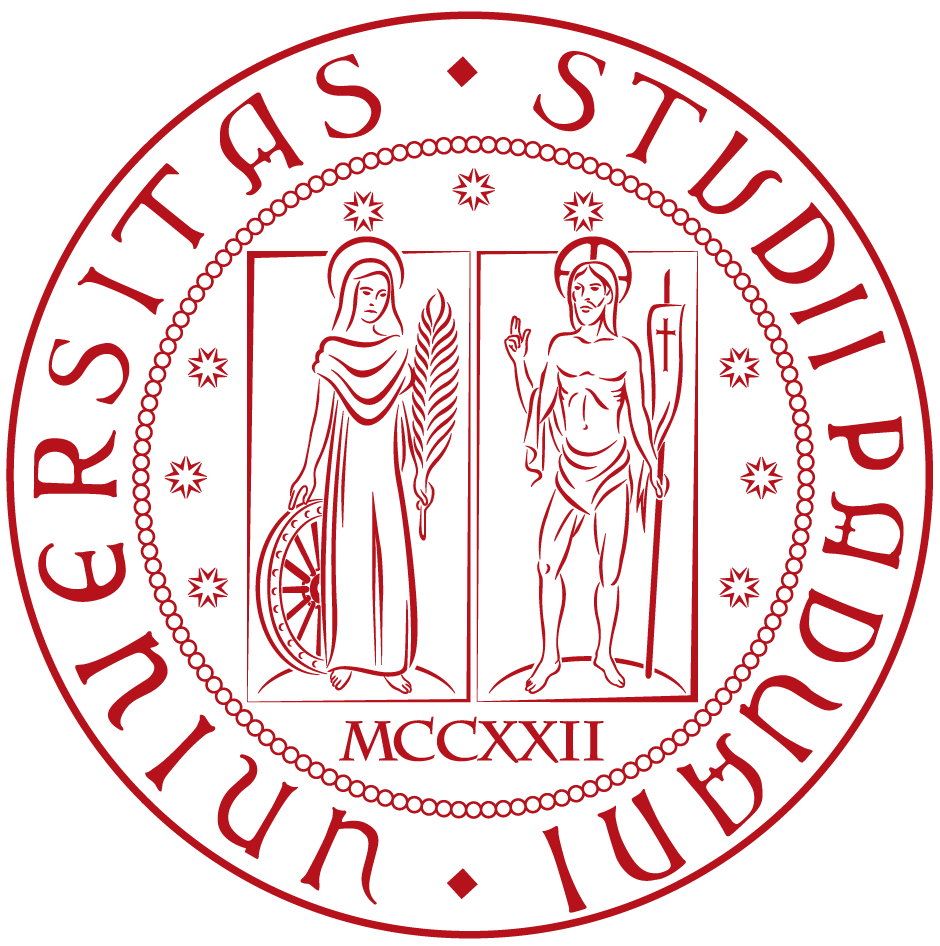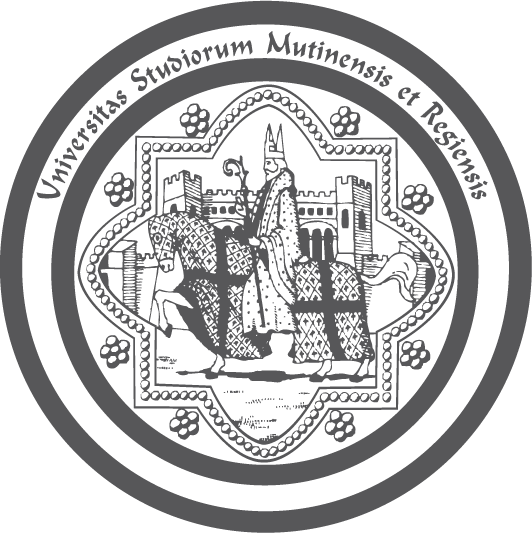Friuli Venezia Giulia: testi
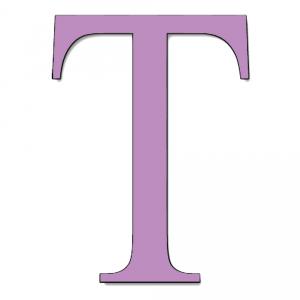
All’indirizzo: http://www.sangiorgioinsieme.it/librionline.html si possono consultare integralmente testi relativi alla storia, alla cultura, all’arte della regione. Sono inoltre disponibili testi narrativi e poetici di alcuni autori friulani contemporanei.
Da Italo Svevo, Corto viaggio sentimentale. VII Gorizia-Trieste (Milano, Mondadori, 1957, p. 108).
Si destò che albeggiava, squassato da un'altra fermata del treno. Saltò in piedi. Era una stazione abbastanza considerevole. Gorizia!
Ma dove era dunque disceso il Bacis? E l’Aghios fece con facilità la sua teoria su quell'abbandono. Certo il Bacis aveva rinunziato alla speranza di trovare quel denaro da quel suo parente a Gorizia e doveva essere disceso a Udine. Chissà quello che avrebbe fatto! Forse avrebbe finito col decidersi di sposare Berta per poter, da padrone, proteggere meglio Anna. Vedeva oramai quella storia tanto da lontano che ogni accomodamento gli pareva possibile. In fondo Anna era l'oggetto dell'amore e tale doveva rimanere. Cara! Cara! Quegli straccini, che la vestivano tanto bene, non doveva abbandonarli.
Verso le sette, quando il treno, con quel suo passo stanco di nottambulo che rincasa, cominciò ad arrampicarsi sul Carso, in un istante di noia, non sapendo che farsi nella sua solitudine, il signor Aghios trasse di tasca il portafogli e palpò le banconote. Sorrise ai propri sensi ingenui che sentivano un dimagrimento del pacchetto. Cosa vuol dire curarsi troppo di una cosa! Per rassicurarsi si chiuse nella vettura, calò le tendine e si mise a contare accuratamente le banconote. Non ve ne erano che quindici! Il Bacis ne aveva trafugate proprio quindici. Oh! Quale canaglia!
Il primo movimento dell'Aghios fu di correre al campanello di allarme. Vi pose persino la mano, ma dopo, da persona timida, esitò davanti a quella minaccia di persecuzione penale. E così ebbe il tempo di ragionare. Che scopo c’era di arrestare quel treno lento, che si batteva al di sopra Barcola, sobborgo di Trieste, per raggiungere il ladro ch'era disceso in una stazione non precisabile prima di Gorizia e da lì s'era avviato col suo bottino verso Torlano ove non c’era ferrovia? Nessunissimo, perché il conduttore del treno non avrebbe mai acconsentito di cambiar rotta e portare lui e tutti i vagoni sgangherati verso la Carnia.
Il signor Aghios si morse le dita. Era tutto ira e vergogna. Vergogna di essersi lasciato turlupinare a quel modo. Addio sentimento della libertà del viaggio, addio benevolenza. Somigliava ad una di quelle figure sintetizzate tanto bene nelle nubi nere e minacciose, ma egli non ricordava né le nubi, né i cani e neppure le belle donne, i suoi aggradevoli monti compagni di viaggio. Alla stazione di Tries* [testo incompleto per la morte dell’autore nel 1928]
Da Carlo Sgorlon, Il trono di legno, (Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1973, pp. 13-14)
I ragazzi di Ontàs mi raccontavano, con un’eco do spavento nella voce, che quel canto porta sfortuna, che la civetta si posa sulle case dove uno sta per morire. Non avevo argomenti per contraddire, ma istintivamente respingevo l’opinione e continuavo a riservare alle civette un posto privilegiato nel mio pensiero. E ogni volta che ne udivo il canto, mi prendeva una voglia insensata di volar giù dalle scale e di infilare una strada qualsiasi, per andare chissà dove.
Altri animali dovevano darsi convegno da noi, certe notti, e io l’indomani me ne accorgevo da un acuto odore di selvatico che aleggiava ancora nei luoghi chiusi: tassi, ricci, conigli selvatici, volpi, faine. La nostra casa era troppo aperta, solitaria e trascurata per non generare nella bestia l’idea che vi si potesse entrare senza rischio, e magari farvi la tana. Alcune venivano a ripararsi durante i temporali estivi, nella cantina o negli ambienti affumicati che si allineavano sotto la tettoria. Vedevo spesso falchi e pojane ruotare intorno lontano, sopra i campi o i magredi, a giri lenti, poi cader giù di peso come fulminati, e sparire tra i pioppi e gli ontani. In primavera e in autunno scorgevo anche grandi uccelli che volavano in strane formazioni, e io seguivo con gli occhi finché non sparivano.
Da Carlo Sgorlon, L’armata dei fiumi perduti (Torino, Utet, 2006, p. 144)
In quel giro di giorni provava una grande stanchezza nello spirito, e non capiva più come avesse potuto ritenere che la guerra contro i Rossi, perduta del ’21, potesse ricominciare. Nella sua voce entrò qualcosa di cupo e di sordo, come se d’un tratto gli fosse caduta addosso la sua condizione di uomo solo, con la famiglia distrutta, che si trovava alla testa del presidio di un popolo senza speranza. Nei momenti liberi si aggirava attorno a Marta come un cane sperduto attorno a un casolare. Una volta le disse:
«Il Friuli e la steppa si somigliano almeno in una cosa.»
«Ossia?»
«Nei nostri cimiteri sono seppelliti molti italiani, e nei vostri molti cosacchi. Una specie di gemellaggio nella morte.»
«Già. Quando partirono i soldati per la Russia, nei paesi suonarono le campane a martello, come quando c’è l’incendio o la grandine.»
Raccontò della partenza di Arturo, Urvàn soggiunse sottovoce, come fossero parole del tutto senza importanza:
«In certo modo siamo vedovi ambedue …»
«Infatti. Che avete in quel fagotto?»
«Roba per Dunaika. Maglie e calze da aggiustare.»
«Datele a me. Ci penso io.»
«Perché vi volete disturbare?»
«Non amo le chiacchiere, Urvàn. Se volete sono qua …»